JULIAN SIMON: PROFETA POCO
RIGOROSO.
Di Ugo Bardi,
Agosto 2004
Uno spettro si aggira
per l’Europa: il famoso rapporto del Club di Roma del 1972 “The Limits to
Growth“(“I limiti alla crescita”). Esorcizzato, denigrato, e demonizzato da
un’intera generazione di economisti, tuttavia risorge dalla tomba nel 2004
nella forma della sua revisione trentennale che ripropone le stesse conclusioni
della prima versione.
L’entusiasmo
della “New Economy” degli anni ’90 sembrava aver consegnato al bidone della
spazzatura della storia tutti i ragionamenti detti “catastrofisti”. Tuttavia,
la ripresa economica è stata annunciata ormai tante volte per l’anno prossimo
che la faccenda ricorda il famoso cartello dietro il banco della pizzicheria:
“oggi non si fa credito, domani si”. Il rallentamento economico dovuto
all’esaurimento delle risorse era stato ampliamente previsto dal Club di Roma;
non potrebbe darsi allora che avessero avuto ragione?
Si tratta allora
di ritornare al dibattito di allora e di rivederlo sulla base dei dati
disponibili. Chi, e su che basi aveva gettato il totale discredito sul lavoro
del Club di Roma? L’opera di Julian Simon (1933-1998) è forse quella che ha
avuto il ruolo più importante in questa vicenda, in particolare il suo libro
“The Ultimate Resource” (La Risorsa Finale) pubblicato nel 1981.
Riletto a più di
venti anni di distanza il libro di Simon dimostra i suoi limiti e le sue
approssimazioni. In particolare, il risultato sorprendente di una rilettura è
che i dati presentati dallo stesso Simon non dimostrano il suo assunto
principale, ovvero che i prezzi delle materie prime abbiano mostrato una
tendenza a lungo termine alla diminuzione. La demolizione del rapporto del Club
di Roma è stata basata soltanto su interpretazioni fantasiose di dati parziali,
ovvero su un approccio sostanzialmente ideologico e propagandistico piuttosto
che scientifico.
“La Risorsa
Finale” è un libro dedicato a sostenere la tesi che le risorse sono abbondanti,
addirittura in aumento, che non ci sono problemi di sovrappolazione, anzi che
più la popolazione aumenta, più ricchezza e benessere si crea. Ci possiamo
domandare su quali basi teoriche Simon sostiene queste idee, ma non è facile
districarsi fra i molti ragionamenti, spesso qualitativi e a volte confusi, del
libro. Può darsi, comunque, che il nocciolo della faccenda si possa trovare a
pagina 49. Inizialmente, Simon dice giustamente che certi minerali, i metalli
per esempio, non si possono dire “esauribili” in quanto li si possono
riciclare. Prosegue poi come segue:
Ci si può domandare, tuttavia, se risorse energetiche non rinnovabili, come
il carbone, il gas o il petrolio siano differenti dai minerali riciclabili in
modo tale che i ragionamenti di prima non si applicano. L’Energia è
particolarmente importante dato che è una “risorsa principale”; l’energia è il
limite chiave per la disponibilità di tutte le altre risorse. Tuttavia, le
nostre risorse energetiche sono non-finite, e il petrolio ne è un
esempioimportante. Il potenziale di produzione di un particolare pozzo può
certamente essere misurato, e perciò è limitato <..> Ma il numero di
pozzi che produrranno petrolio, come pure la quantità dello stesso, non sono
dati noti o misurabili oggi e probabilmente non lo saranno mai. Anche se
facciamo l’assunzione non realistica che si possa censire il numero totale di
pozzi potenziali sulla terra e che si possa arrivare a una stima ragionevole
del petrolio che si potrà ottenere con l’attuale tecnologia (o di tecnologie
che potranno essere sviluppate nei prossimi cento anni), dovremmo tuttavia
tener conto delle future possibilità dele sabbie e degli scisti bituminosi – un
compito difficile. Dovremmo poi considerare la possibile conversione del
carbone in petrolio. Anche quella è una cosa che potremmo fare, tuttavia non
dovremmo considerare la quantità risultante come “finita” e “limitata”. C’è poi
il petrolio che potremmo produrre non da fossili ma da nuovi cereali, come
l’olio di palma, l’olio di soia, e così via. Chiaramente, non esiste alcun
limite significativo a questa sorgente, con l’eccezione dell’energia solare. Se
teniamo conto della sostituzione dell’energia nucleare e di quella solare per
il petrolio, dato che quello che vogliamo sono i servizi che il petrolio ci fa,
non necessariamente il petrolio stesso, la nozione di limite è ancora più
insensata. Ovviamente, prima o poi il sole finirà. Ma anche se il nostro sole
non fosse così vasto com’è, ci possono benissimo essere altri soli in altri
luoghi.
Ora, cosa
dobbiamo pensare di questo minestrone tecnological-filosofico? Per prima cosa,
Simon sembra dire che se non si sa esattamente l’ammontare di qualcosa, non si
può dire che quella tal cosa non è infinita. Questo è talmente assurdo che non
vale neanche la pena di criticarlo: cosa dovremmo pensare se qualcuno che si
beve una birra dalla lattina venisse a sostenere che non si può dire che questa
birra “non è infinita” dato che non sa esattamente quanta ce ne rimane dentro?
A parte questo
punto, non tanto sbagliato quanto ridicolo, Simon tira dentro nel ragionamento
un sacco di cose, oli vegetali, energia solare, nucleare, eccetera, per poi
sparare una cosa che è semplicemente una sciocchezza: che per l’olio di palma,
di soia e altro “non esiste alcun limite significativo.” Addirittura, dice che
la nozione di limite è “insensata”. Ma scherziamo? Non diciamo che si dovrebbe
fare come aveva fatto Mao Zedong ai suoi tempi, ovvero mandare gli
intellettuali a zappare, ma se un intellettuale si prende la briga di parlare
di agricoltura dovrebbe fare un minimo di sforzo per cercare di dire cose
sensate. Anche qui, forse, è meglio non attardarsi con le critiche per carità
di patria.
Il testo
riportato qui sopra da un idea del grado di confusione che pervade tutto il
libro. In effetti, l’organizzazione del testo è molto carente, con concetti
ripetuti più di una volta, certi dati messi parte nel testo e in parte
nell’appendice, una generale tendenza “aneddotica” nel presentare dati parziali
e da quelli trarre conseguenze generali.
A parte la
confusione, comunque, scavando nella moltitudine di concetti del libro, si
riesce anche a tirarne fuori una certa logica. In effetti, Simon potrebbe
essere stato uno dei primi a esprimere per il grande pubblico il concetto che
oggi va sotto il nome di “piramide delle risorse”. Ovvero, è noto che le
risorse minerarie si trovano a vari gradi di concentrazione; quelle più concentrate
sono anche le più rare e questo crea, appunto, la “piramide.” La logica vuole
che si cominci a estrarre le risorse più concentrate, che sono le più
convenienti economicamente. Esaurite le risorse a basso costo di estrazione,
l’incremento dei prezzi che ne consegue porta a estrarre risorse più diluite. A
questo punto, miglioramenti tecnologici e l’inventiva umana (la “risorsa
finale”) fanno si che i prezzi di estrazione si abbassino e tutto va per il
meglio nel migliore dei mondi.
Va da se che
questo concetto si basa su un atto di fede, ovvero che l’inventiva umana riesca
sempre ad abbassare i costi di estrazione per risorse sempre più
difficili da estrarre. Altrimenti si arriverebbe ad essere a corto di risorse
non perché queste sono esaurite fisicamente, ma perché non ci si può più
permettere di estrarle. Per cui, i sostenitori del concetto di piramide delle
risorse si trovano a basarsi fortemente sul record storico come prova che i
prezzi delle materie prime diminuiscono nel tempo, nonostante il progressivo
esaurimento. In effetti, la linea di fondo del libro di Simon è esattamente
questa: i prezzi delle materie prime sono sempre diminuiti nella storia. Da
questo Simon deduce che diminuiranno sempre. Ma, a parte il fatto che questa
estrapolazione è quantomeno azzardata, è proprio vero quello che dice Simon?
Curiosamente, gli stessi dati presentati nel libro non la dimostrano affatto!
Per dimostrare la
sua tesi, Simon calcola i prezzi “reali” (ovvero al netto dell’inflazione) per
certe materie prime e dice che i prezzi così ottenuti sono una misura della
“scarsità delle risorse”. Ora, ci sono molti problemi con questo ragionamento,
dove Simon fra una discreta confusione (forse volutamente) fra il concetto di
scarsità inteso in senso fisico (quantità disponibile) e il concetto di
scarsità inteso in senso economico (definito come proprietà di una merce
oggetto di scambi monetari). Ma non dilunghiamoci su questo punto. Piuttosto,
cosa possiamo dedurre dalle figure presentate? Abbiamo 4 metalli (alluminio,
rame, piombo e ferro), la farina, e due combustibili fossili (carbone e
petrolio); un po’ poco per trarne deduzioni su scala planetaria. Vediamo
comunque di esaminare i dati disponibli in dettaglio. Per ogni materia prima,
Simon presenta due diagrammi con metodi diversi per correggere i prezzi
corretti per l’inflazione. In un caso, divide i prezzi per i salari (forse
salari medi, ma questo non è spiegato nel libro) in un altro li divide per
l’indice dei prezzi al consumo.
Per i casi
mostrati nel libro, il rapporto prezzi/salari mostra una evidente diminuzione
con il tempo su tutto il periodo storico considerato. Ma questa grandezza non
rappresenta una vera correzione per l’inflazione. Cosa vuol dire far vedere
che, per esempio, il rapporto prezzo/salari del carbone scende progressivamente
dal 1800 a oggi? E’ ovvio che un minatore dell’800 con piccone e mazza era
enormemente meno efficiente di un minatore moderno con il suo martello
pneumatico, e questo si deve riflettere sui prezzi. Ma questo vuol dire semplicemente
che abbiamo imparato ad estrarre il carbone più velocemente, ma non ci dice
niente a proposito della scarsità fisica del carbone. Semmai, il fatto che ci
sia una discesa rapida in tempi lontani ma che i prezzi tendano a un valore
quasi costante in tempi moderni ci dovrebbe dire che qualcosa si è inceppato
nel meccanismo che Simon propone, ovvero dai dati sembrerebbe di poter dedurre
che in tempi recenti il progresso tecnologico ha rallentato oppure che la
risorsa comincia a scarseggiare fisicamente (oppure, tutte e due le cose). Su
questa ovvia questione, Simon non fa nessun commento nel suo libro.
In realtà, queste
misure del rapporto prezzi/salari lasciano il tempo che trovano e nessun
economista serio le usa come correzione dell’inflazione. Il modo corretto per
misurare i prezzi “reali” al netto dell’inflazione su tempi lunghi è noto e
accettato da tutti. Si tratta di riferirsi all’indice dei prezzi al consumo
(IPC), ovvero a un “paniere” di beni che esclude energia e alimentari,
considerati troppo volatili. Ora, se guardiamo le figure presentate da
Simon stesso, vediamo che per questo tipo di correzione non c’è nessuna chiara
tendenza che i prezzi reali siano in continua diminuzione da un secolo o piu’.
Solo nel caso dell’alluminio questa tendenza è evidente. Nel caso del piombo i
prezzi corretti per l’inflazione sono approssimativamente costanti. Altre
risorse (petrolio, rame, ferro) hanno un andamento a “U” con aumenti di prezzi
negli ultimi decenni, mentre nel caso del carbone, i prezzi sono evidentemente in
aumento!
Per chiarificare
la faccenda, possiamo presentare dati più moderni di quelli di Simon, che
comunque non cambiano le cose. Per prima cosa, ecco un “paniere” di materie
prime che ne include 17 ed è pertanto molto più significativo dei dati
sparpagliati presentati da Simon.
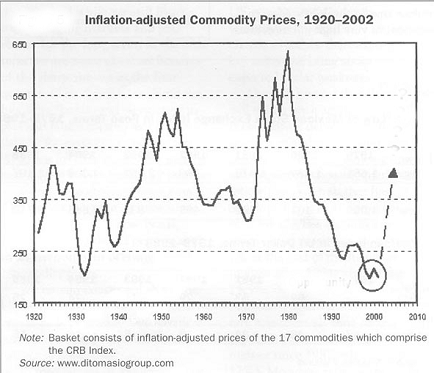
Secondo questi dati,
il costo medio delle materie prime ha fortemente oscillato durante gli ultimi
80 anni. Non si può dire che sia aumentato, ma neanche che sia diminuito.
Il “paniere” di
cui sopra non comprende il petrolio, vediamo dunque anche questo dato (sorgente
ASPO – www.peakoil.com ).
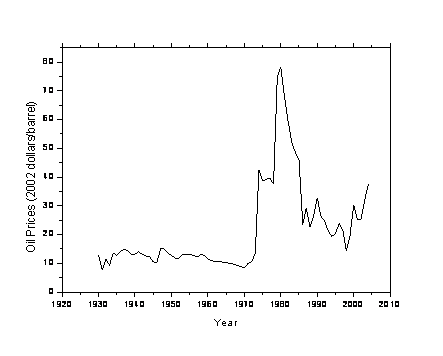
Anche qui ci sono
forti oscillazioni, ma è chiaro che i prezzi del petrolio non sono diminuiti
negli ultimi 70 anni. Secondo gli stessi dati presentati da Simon, per
trovare una fase di chiara tendenza alla dimunuzione dei prezzi petroliferi
bisogna andare indietro ai due decenni 1860-1880, ma da quel periodo remoto
difficilmente possiamo trarre conclusioni rilevanti per i nostri giorni.
Allora, per
concludere, tutta la teoria di Simon è basata su deduzioni che sono
semplicemente false. Non c’è nessuna evidenza dai dati sperimentali che i
prezzi delle materie prime in generale tendano a diminuire a lungo termine.
E’ curioso (ma
forse non troppo) che questo libro raffazzonato, confuso e fondamentalmente
falso, abbia avuto tanto effetto, al punto che oggi il fatto che “i prezzi
delle materie prime sono andati giù” è una frase ripetuta fino alla nausea da
tutti quelli che si sentono in dovere di criticare il lavoro del Club di Roma.
Persino Bjorn Lomborg, il presente campione degli abbondantisti, e anche una
persona indubbiamente intelligente e preparata, racconta di “aver visto la
luce” leggendo il libro di Simon.
In parte, il
successo del libro di Simon è dovuto a certe qualità positive di Simon stesso.
La sua capacità di scrivere in modo accattivante, la sua indubbia brillantezza
e l’originalità di certe sue idee. Una cosa che, poi, ha avuto una grandissima
risonanza è stata la scommessa fatta (e vinta) da Simon con un suo oppositore
(Paul Ehrlich) sull’andamento dei prezzi delle materie prime. Il povero Ehrlich
si è trovato per pura sfortuna ad aver accettato la scommessa proprio nel
momento in cui i prezzi erano al massimo di una delle loro cicliche
oscillazioni. Questa scommessa ha colpito la fantasia di molti e ha dato un
aura di infallibilità a Simon, che aleggia intorno alla sua figura tuttora.
Tuttavia, una
scommessa su due soli momenti nella storia non dimostra niente (vedi http://www.aspoitalia.net/documenti/bardi/erlichsimon2004/erlichsimon2004.html).
Puo’ darsi che alla fine dei conti quello che Paul Ehrlich disse di Julian
Simon sia una buona definizione. “Simon è come quel tale che era saltato giù
dall’Empire State Building e che diceva che tutto andava benissimo mentre passava
il decimo piano”